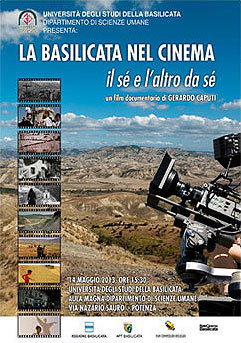Ad Avigliano, il 16 luglio si svolge la festa della Madonna del Carmine. La statua è portata in processione dal paese al Monte, dove, a quota 1230 metri, sorge il santuario a Lei dedicato nel 1696. Durante la seconda domenica di settembre la statua è riportata, sempre in processione, in paese.
Il rapporto tra Maria e gli aviglianesi è stato sempre molto intenso:
- a Lei sono andate le donne col volto coperto da una tovaglia bianca sostenuta da una corona di spine per chiedere acqua per le campagne assetate;
- a Lei sono andati, scalzi, i contadini pazienti per domandarle di salvare l’asino e la pecora;
- a Lei vanno perché un figlio non cada nelle reti della droga;
- a Lei chiedono perché li assista nella ricerca di un lavoro.
In questo paese tutto ciò che Maria rappresenta simbolicamente è confermato dall’affetto che la circonda.
La sera della festa del 16 luglio la Pro-Loco organizza in piazza i ‘Quadri plastici’ i quali propongono alla meditazione del pubblicoalcuni momenti della Passione di Cristo secondo la visione data dai pittori, spesso anche lucani.