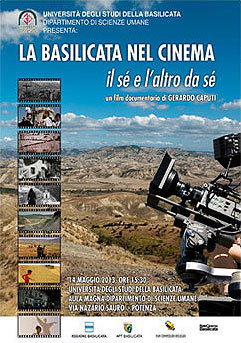Pianta della Cattedrale.
Pianta della Cattedrale.
Pianta della cattedrale come appare oggi. Nel riquadro una riproduzione di un'antica Pianta del 1544.
La costruzione della chiesa stata iniziata nel 1238 e terminata nel 1270. LÕedificio originario precedente era a una sola navata a forma di "T" (tau) e in esso si officiava il rito greco. La chiesa , dunque, "nuovamente da" fondamenti riedificata, e costrutta sopra l'istessi fondamenti della suddetta chiesa antica con più magnificenza e struttura" (Nelli).
La chiesa viene sviluppa in tre navate divise da una serie di colonne, un transetto, che verrˆ allungato nel Settecento.
Nel 1544 possiede ben 33 altari, in seguito ridotti a 12. Una sua nuova consacrazione con rito latino avviene nel 1627 ad opera di mons. Fabrizio Antinori. Nel secolo successivo si apportano le pi importanti modifiche: mons. A. De Los Ryas Colminarez rifà, nel 1678, il pavimento. Agli inizi del secolo successivo mons. Brancaccio amplia le originarie bifore del periodo normanno, e altri aspetti della struttura (come attesta la lapide posta sull'attuale portale d'ingresso); i lavori di modifica proseguono con mons. Mariconda, a partire dal 1726. Egli fa ingrandire la parte del presbiterio per collocarvi un Coro pi ampio del primo (1729).
(Il disegno tratto da: Franco Pede (a cura di), La cattedrale di Matera, Matera, sd.)
 Facciata principale e Campanile, XIII secolo.
Facciata principale e Campanile, XIII secolo.
La chiesa si presenta con una facciata principale, rivolta ad Occidente, in stile romanico-pugliese a salienti interrotti. E’ caratterizzata da una linea di 12 archetti pensili che sul frontone, nella parte superiore, diventano rampanti. Le 12 colonnine e, ai lati, le 4 colonne sovrapposte a due a due, sono simbolo dei 12 Apostoli e dei 4 Evangelisti.
Il materiale adoperato per la costruzione è il tufo della Vaglia.
Il Campanile, alto 52 metri, è stato costruito contemporaneamente alla chiesa ma con un'aggiunta in epoca successiva. E' in stile longobardo. A base quadrata, si sviluppa in quattro ripiani di cui tre con bifore e uno con monofore, tutti scanditi da cornici marcapiano. La cuspide a piramide quadrangolare, con cui termina, è posta nel XVIII secolo.
 Rosone, XIII secolo, facciata principale.
Rosone, XIII secolo, facciata principale.
Il rosone, che sovrasta il portale, formato da 16 raggi con 3 figure nell'atto di far girare questa "ruota", chiaro riferimento alla ruota della vita; lo sovrasta un'immagine di san Michele.
 Frontone, XIII secolo, particolare di destra e di sinistra.
Frontone, XIII secolo, particolare di destra e di sinistra.
 Leone che ingoia un uomo, scultura lapidea, XIII secolo, particolare, facciata principale.
Leone che ingoia un uomo, scultura lapidea, XIII secolo, particolare, facciata principale.
Fin dalla pi remota antichità le rappresentazioni dei leoni sono legate all'idea di forza, crudeltà ed autorità. Nel Cristianesimo medievale le immagini del leone simboleggiano la paura degli uomini di fronte alla forza ed alla cattiveria di questo animale divenuto l'espressione della potenza del male e per questo assimilato a Satana, il nemico dell'uomo spirituale. Per tale motivo il leone figura spesso in vari manufatti delle chiese romaniche.
 Fiancata destra, esterno, XIII secolo.
Fiancata destra, esterno, XIII secolo.
Sulla fiancata destra gli archetti continuano i motivi della facciata principale. In essa si aprono due porte intermezzate da un'edicola con colonnine su mensole. La prima porta detta "Porta della piazza" o anche "Porta di Abramo" per la formella contenuta nella lunetta e raffigurante il patriarca. Gli stipiti e gli archivolti sono ornati da fregi a motivi vegetali. E' attribuita a Melchiorre da Montalbano (scultore documentato 1273-1279).
La seconda detta "Porta dei leoni" perché ornata da colonnine alla cui base siedono i due animali aventi tra le fauci un uomo; tali colonnine reggono un protiro cuspidato. Gli archivolti sono scolpiti da motivi vegetali.
(cfr Scheda - Melchiorre da Montabano).
 Porta dei leoni, scultura lapidea, XIII secolo, fiancata destra.
Porta dei leoni, scultura lapidea, XIII secolo, fiancata destra.
Sulla fiancata destra vi sono due porte, di cui una detta "Porta dei leoni", perché ornata da colonnine alla cui base siedono i due animali aventi tra le fauci un uomo; tali colonnine reggono un protiro cuspidato. Gli archivolti sono ornati di motivi vegetali, sull'architrave fanno bella mostra 5 volti di ragazze, simbolo delle virtù.
 Soffitto, dipinto su tavola, XVIII secolo, particolare, navata sinistra.
Soffitto, dipinto su tavola, XVIII secolo, particolare, navata sinistra.
Il soffitto, originariamente a capriate, stato ricostruito con uno a piano ligneo sul quale sono state dipinte scene di vario tipo. Le decorazioni sono state avviate da mons. Brancaccio nel 1703 e portate a termine nel 1776 da mons. Zunica (1776-1796).
 Cristofaro Battimelli, Altare della Madonna della Bruna, marmo intarsiato e policromo, 1731, navata sinistra.
Cristofaro Battimelli, Altare della Madonna della Bruna, marmo intarsiato e policromo, 1731, navata sinistra.
L'altare stato eseguito a Napoli nel 1731 dallo scultore Cristofaro Battimelli su disegno di Cristoforo Formabo.
La cona, anch'essa in marmo, risale al 1706 ed stata realizzata da Francesco Cimafonte, napoletano. In essa sistemato l'affresco Madonna della Bruna con Bambino risalente al 1270 circa. Ai lati dell'affresco vi sono le statue dei profeti Davide e Isaia.
Fino al 1776 questo altare aveva la funzione di altare maggiore ed era collocato nel presbiterio. - "Legato alla storia dell'altare il "Breve apostolico" del 15 gennaio 1578, con cui papa Gregorio XIII riconosceva all'altare il "privilegio" di salvare un'anima dal Purgatorio per ogni Messa che vi si celebrasse." (Di Pede).
 Rinaldo daTaranto (?), Madonna della Bruna con Bambino, affresco, 1270 circa, navata sinistra.
Rinaldo daTaranto (?), Madonna della Bruna con Bambino, affresco, 1270 circa, navata sinistra.
Questo affresco un tempo era collocato nella controfacciata, a sinistra della porta d'accesso, e faceva parte di un ciclo che rivestiva l'interno dell'intera chiesa. Nel 1576 fu ritagliato, fasciato di ferro e collocato sull'altare attuale. Concepito in stile bizantino, opera del cosiddetto "Maestro della Bruna", forse Rinaldo da Taranto.
 Altare di S. Giovanni da Matera contenente l'urna con i resti mortali del Santo.
Altare di S. Giovanni da Matera contenente l'urna con i resti mortali del Santo.
 Urna contenente i resti mortali di San Giovanni da Matera.
Urna contenente i resti mortali di San Giovanni da Matera.
San Giovanni da Matera fu un eremita che, secondo la tradizione, ricevette l'ordine da S. Pietro di restaurare la Chiesa (un secolo dopo ad Assisi il Crocifisso ordinerà la stessa cosa a Francesco). Egli fonda una Congregazione di monaci detti, dal nome della località, di Pulsano, ai quali applica la regola benedettina in modo rigido. Muore in fama di santità nel 1139. La sua Congregazione avrà una certa incidenza sulla religiosità meridionale, ma verrà soppressa nel 1379 da papa Urbano VI (1378-1389) per essersi schierata dalla parte dell'antipapa Clemente VII (1378-1394).
 Francesco da Martina, S. Anna e Maria col Bambino, tela, 1633, e Altare di SantÕAnna, navata sinistra.
Francesco da Martina, S. Anna e Maria col Bambino, tela, 1633, e Altare di SantÕAnna, navata sinistra.
L'altare e la tela confermano la particolare diffusione in Basilicata del culto di sant'Anna, soprattutto presso le donne incinte o le mamme che avevano il seno arido. Ciò da mettersi in relazione con la biografia della madre di Maria. Ella, pur non essendo una figura di cui si parli nei Vangeli, molto presente nell'immaginario popolare grazie a quanto scritto nel Protovangelo di Giacomo. In esso si narra, infatti, la mortificazione di Anna, donna sterile ed ormai vecchia. La sterilità era considerata dalla cultura ebraica come un segno della maledizione di Dio. Ma Dio mandò ad Anna un angelo per annunziarle che "presto sarebbe sbocciata dalla radice inaridita un giglio candido, in quella squallida casa si sarebbe aperta la rosa mistica, presto sarebbe venuta una fanciulla piena di sole", Maria.
 Francesco da Martina, Sant'Anna e Maria col Bambino, tela, 1633, navata sinistra.
Francesco da Martina, Sant'Anna e Maria col Bambino, tela, 1633, navata sinistra.
 Cappellone del SS. Sacramento, XVI secolo, navata sinistra.
Cappellone del SS. Sacramento, XVI secolo, navata sinistra.
Originariamente era diviso in due cappelle poste una di seguito all'altra e con pi altari.
E' stato poi ridotto ad un solo vano con altare di marmo pario, oggi dedicato alla Madonna del Rosario.
 Giulio Persio, Cappella dell'Annunziata (anche 'della Nunziatella'), fine XVI secolo, navata sinistra.
Giulio Persio, Cappella dell'Annunziata (anche 'della Nunziatella'), fine XVI secolo, navata sinistra.
E' un vero gioiello creato da Giulio Persio negli anni Ottanta del Cinquecento. Ha la volta a cassettoni in pietra dura con al centro l'altorilievo l'Eterno Padre benedicente.
L'altare in pietra fu sostituto nel 1750 e quest'ultimo ornato della scultura lapidea
raffigurante l'Annunciazione fra i Ss. Rocco e Caterina d'Alessandria; al di sopra vi una Pietà non rifinita.
Le due pareti laterali hanno sedili in pietra in corrispondenza delle nicchie terminanti a forma di conchiglia e un tempo decorate.
 Giulio Persio, Pietà, pietra policroma, 1544, particolare, Cappella dell'Annunziata, navata sinistra.
Giulio Persio, Pietà, pietra policroma, 1544, particolare, Cappella dell'Annunziata, navata sinistra.
Il gruppo scultoreo fa parte dell'altare dedicato all'Annunziata nell'omonima Cappella tutta in pietra dura creata da Giulio Persio sul finire del Cinquecento.
 Altobello Persio, Cappella del Presepe, 1534, navata sinistra.
Altobello Persio, Cappella del Presepe, 1534, navata sinistra.
La Cappella contiene questo Presepe di grandi dimensioni di pietra policroma scolpita da Altobello Persio, che lo ha realizzato in collaborazione con Sannazzaro di Alessano.
Una delle caratteristiche rappresentata dalla stella cometa, la quale illuminata con luce diretta dall'esterno.
Il Presepe interessante non soltanto perché le figure che lo popolano richiamano persone e volti dei Sassi di Matera, ma anche perché "una tra le opere pi considerevoli degli artisti meridionali del sec. XVI" (Contillo).
In epoca successiva sono state aggiunte sculture provenienti da altari e monumenti funerari del XIII e XIV secolo (il grifo, l'aquila, due leoni, gli ornati).
L'altare marmoreo del 1725. Sul lato destro collocata la tomba del vescovo Giuseppe Sparàno (1775-1776).
(cfr. Scheda - Altobello Persio)
 Altobello Persio, Bambinello, pietra policroma, 1534, Cappella del Presepe, navata sinistra.
Altobello Persio, Bambinello, pietra policroma, 1534, Cappella del Presepe, navata sinistra.
Il Presepe di grandi dimensioni, stato scolpito da Altobello Persio. E' interessante non soltanto perché le figure che lo popolano richiamano persone e volti dei Sassi di Matera, ma anche perché "una tra le opere pi considerevoli degli artisti meridionali del sec. XVI" (Contillo).
(cfr. Scheda - Altobello Persio)
 Altobello Persio, Madonna e Bambinello, pietra policroma, 1534, Cappella del Presepe, navata sinistra.
Altobello Persio, Madonna e Bambinello, pietra policroma, 1534, Cappella del Presepe, navata sinistra.
(cfr. Scheda - Altobello Persio)
 Altobello Persio, San Giuseppe e un angelo, pietra policroma, 1534, cappella del Presepe, navata sinistra.
Altobello Persio, San Giuseppe e un angelo, pietra policroma, 1534, cappella del Presepe, navata sinistra.
Presepe di grandi dimensioni, è interessante non soltanto perché le figure che lo popolano richiamano persone e volti dei Sassi di Matera, ma anche perché è "una tra le opere più considerevoli degli artisti meridionali del sec. XVI" (Contillo).
(cfr. Scheda - Altobello Persio)
 Medaglioni, affreschi. XVII secolo, Cappella del Presepe, navata sinistra.
Medaglioni, affreschi. XVII secolo, Cappella del Presepe, navata sinistra.
La volta della cappella affrescata con figure di Sibille e Profeti; ciascun personaggio circoscritto in un medaglione ornato di cortine.
 Madonna della Bruna, manichino, XVIII secolo, lato sinistro del transetto.
Madonna della Bruna, manichino, XVIII secolo, lato sinistro del transetto.
E’ l’effige portata in processione il giorno della festa annuale del 2 luglio.
 Altobello Persio, Dossale di S. Michele, pietra policroma, 1539, lato sinistro del transetto.
Altobello Persio, Dossale di S. Michele, pietra policroma, 1539, lato sinistro del transetto.
L'ordine mediano formato dall'immagine della Madonna con Bambino con ai lati i Ss. Simone, Giuda Taddeo, Giacomo e Caterina. La predella a bassorilievo e propone l'Ultima cena.
Lo scultore ha apposto la propria firma sul basamento della statua della Madonna.
(cfr. Scheda - Altobello Persio)
 Presbiterio, 1640.
Presbiterio, 1640.
Il presbiterio sopraelevato rispetto al piano della navata da 7 gradini fatti costruire dall'arcivescovo Simone Carafa (1638-1647). L'attuale sistemazione gli stata data da mons. Francesco Zunica (1776-1796) allorché questi fece sistemare, nel 1785, il mastodontico altare maggiore trasportato a Matera dall'Abbazia benedettina di (=>) Montescaglioso.
Sullo sfondo collocata una grande cona contenente la pala di Fabrizio Santafede, da lui dipinta nel 1580.
 Cupola emisferica, interno, 1738, presbiterio.
Cupola emisferica, interno, 1738, presbiterio.
Sovrastante il presbiterio, questa cupola emisferica racchiusa in un tiburio sviluppato sulla originaria pianta quadrata, propria del periodo romanico.
 Altare maggiore, marmo policromo, XVII secolo, presbiterio.
Altare maggiore, marmo policromo, XVII secolo, presbiterio.
Questo altare, dalle misure mastodontiche, apparteneva all'Abbazia benedettina di (=>) Montescaglioso fino al 1776, anno in cui l'arcivescovo Francesco Zunica (1776-1796) lo fece trasportare a Matera. Fu montato nell'attuale sede nel 1785, in sostituzione dello altare della Madonna della Bruna, sistemato in fondo alla navata di sinistra, dove ancora oggi.
 Abside.
Abside.
L'abside ha avuto l'attuale forma poligonale dopo la sistemazione nel vano del presbiterio dell'altare maggiore trasportato dall'Abbazia di (=>) Montescaglioso da mons Zunica nel 1785. Le dimensioni dell'altare riducevano lo spazio per il Coro ed allora il Capitolo della Cattedrale creò dietro l'altare un vano in grado di accogliere i numerosi stalli del Coro. Tale operazione finì col modificare la pianta della chiesa che diventò così a croce latina.
 Fabrizio Santafede, Vergine con Bambino e Santi, tela, 1580, abside.
Fabrizio Santafede, Vergine con Bambino e Santi, tela, 1580, abside.
La cona grande stata acquistata dal canonico Sanità e da questi offerta alla Cattedrale. Raffigura la Vergine con Bambino; in primo piano gli apostoli Pietro e Paolo fiancheggiati dai Ss. Giovanni Battista ed Evangelista; dietro i Ss. Biagio e Donato; in basso il canonico Sanità, il mecenate.
Sotto la pala collocata una predella in cui sono raffigurati: la Visione di S. Eustachio, la Conversione di S. Paolo, Salomé con la testa del Battista, la Visitazione, il Martirio dei Ss. Pietro e Giovanni evangelista.
Nella cimasa un' ovale contiene una SS. Trinità, di autore ignoto.
 Giovanni Tantino, Coro ligneo, 1453, abside.
Giovanni Tantino, Coro ligneo, 1453, abside.
Il Coro ligneo "egregium” è collocato nell’abside di forma poligonale. Consta di 60 stalli, distribuiti in due ordini. Lo ha scolpito la mano di Giovanni Tantino di Ariano Irpino.
Ha pannelli raffiguranti scene di vita biblica, di anacoreti e di animali. Esso, pur se è stato rimaneggiato nel 1729, rappresenta "una delle pagine più interessanti della storia figurativa della Basilicata del secolo XV" (Grelle).
 Giovanni Tantino, Coro ligneo, 1453, scorcio, abside.
Giovanni Tantino, Coro ligneo, 1453, scorcio, abside.
 Giovanni Tantino, Figura di leone, 1453, particolare, Coro ligneo.
Giovanni Tantino, Figura di leone, 1453, particolare, Coro ligneo.
Il Coro, scolpito da Tantino originario di Ariano Irpino, ha dei pannelli con figure di animali, scene di vita di anacoreti e scene bibliche.
Tale Coro rappresenta "una delle pagine pi interessanti della storia figurativa della Basilicata del secolo XV" (Grelle).
 Giovanni Tantino, Particolari, 1453, Coro ligneo.
Giovanni Tantino, Particolari, 1453, Coro ligneo.
 Giovanni Tantino, Madonna col Bambino, 1453, particolare, Coro ligneo.
Giovanni Tantino, Madonna col Bambino, 1453, particolare, Coro ligneo.
Una delle due portelle d'ingresso al Coro propone una Madonna con una mano enorme rispetto al corpo ed un panneggio imponente: entrambi rinviano all'immagine di un'austera, operosa e protettiva contadina lucana.
 Soffitto, dipinto su tavola, XVIII secolo, particolare, navata destra.
Soffitto, dipinto su tavola, XVIII secolo, particolare, navata destra.
Il soffitto, originariamente a capriate, stato ricostruito con uno a piano ligneo sul quale sono state dipinte scene di vario tipo. Le decorazioni sono state avviate da mons. Antonio Maria Brancaccio nel 1703 e portate a termine nel 1776 da mons. Zunica (1776-1796).
 Altare "dello scannaggio", marmo policromo, 1725, e, di Vito A. Conversa, Polittico, 1754, navata destra.
Altare "dello scannaggio", marmo policromo, 1725, e, di Vito A. Conversa, Polittico, 1754, navata destra.
Questo altare detto "dello scannaggio" in quanto, in passato, nei suoi pressi si pagava "il soldo" dovuto per ogni capo di bestiame macellato.
Sopra c'è il polittico dipinto dal Conversa, composto da (in senso orario) la Maddalena, S. Carlo, Porziuncola, San Biagio, Sant'Orsola.
 Altare di S. Eustachio
Altare di S. Eustachio
La tela sull'altare illustra un episodio saliente della vita di sant’Eustachio: l’apparizione nella foresta di un cervo con una croce luminosa tra le corna, cervo che parla al cacciatore e lo porta alla conversione.
Il cacciatore si chiamava Placido (che col battesimo assume il nome di Eustachio), era un generale di Traiano, imperatore romano dal 98 al 117. Dopo la conversione, fu privato di tutte le sue sostanze, della moglie e dei figli. Traiano lo richiamò al comando dell’esercito per arginare i barbari invasori e Placido/Eustachio vinse e riottenne beni e famiglia.
Il nuovo imperatore, Adriano, saputo che il generale era cristiano, riservò a lui e ai familiari un atroce martirio: li pose in un toro di rame, sotto il quale fece bruciare il fuoco per tre giorni.
 Ignoto, Crocifisso, scultura lignea, XVII secolo, navata destra.
Ignoto, Crocifisso, scultura lignea, XVII secolo, navata destra.
Ricavato da un tronco pieno, questo "Christus patiens" di un Òpotente realismo che trasmette suggestioni patetiche intense, accentuate dalla posizione del capo lievemente reclinato, dalle palpebre abbassate e dalla bocca, dischiusa nella serena fissitˆ della morte, dalla leggera torsione del busto sulle ginocchia piegateÓ (Altavilla).
 Carlo Rosa, S. Gaetano da Thiene, tela, 1652, navata destra.
Carlo Rosa, S. Gaetano da Thiene, tela, 1652, navata destra.
Il culto del santo stato introdotto a Matera sul finire del Seicento. Esso veniva proposto soprattutto ai sacerdoti
- come modello di umiltà (in tempi in cui tutti levavano la cresta della superbia, accusando gli altri di corruzione),
- come modello di sacerdote che aveva operato con intelligente carità per la diffusione della Controriforma (egli sosteneva che tutte le riforme non contano nè hanno valore se non cominciano da noi stessi), alla quale il clero lucano si mostrava refrattario;
- come modello dell'ortodossia cattolica contro le infiltrazioni protestanti (a Napoli egli si era opposto strenuamente ai valdesi che cercavano spazi anche nel Sud).
 Domizio Persio, Madonna col Bambino tra i Ss. Ilario e Giovanni da Matera, tela, 1592, navata destra.
Domizio Persio, Madonna col Bambino tra i Ss. Ilario e Giovanni da Matera, tela, 1592, navata destra.
La tela di questo pittore, nato a Matera e figlio del famoso scultore (=>) Altobello Persio, è collocata a ridosso della Porta di Abramo. Fu dipinta per essere destinata alla chiesa dalla “Palomba”.
Il suo valore didattico è interessante: va notato, infatti, la contemporanea presenza dei due santi, entrambi importanti ma a diverso livello: il primo, sant’Ilario, era noto al clero, il secondo, S. Giovanni, noto al popolo materano. Ilario, nato nel V secolo a Poitiers, in Francia, era portato a campione come difensore dell’ortodossia cattolica, cioè di quella dottrina del Concilio di Nicea (325), dove era stato fissato il principio enunciato con le parole “Credo in Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, nato dal padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero”; Giovanni era colui che aveva ricevuto da san Pietro, in una visione, l’invito a “restaurare” la Chiesa ed egli aveva fondato allora la Congregazione dei Benedettini di Pulsano.
L’accostamento dei due santi si comprende se si tiene presente la data in cui la tela è stata dipinta (1592) e cioè un periodo in cui i vescovi cercano di far praticare nella regione le idee del Concilio di Trento (1545-1563).
 Giudizio universale, affresco, XIII e XIV secolo, particolare, navata destra.
Giudizio universale, affresco, XIII e XIV secolo, particolare, navata destra.
Dietro il fonte battesimale sono stati scoperti di recente sulla parete frammenti di un ciclo di affreschi. L'insieme misura m.5,40 x 3,92 ed suddiviso in pi registri:
- registro superiore, del XIII secolo:
raffigurazione del Giudizio universale e S. Michele, attribuita a Rinaldo da Taranto;
- registro inferiore: Madonna con Bambino e i Ss. Pietro, Giuliano e Luca, di Ignoto del XIV secolo.
Le scene dell'inferno mostrano la punizione inflitta ai peccatori; nelle fiamme sono posti ad ardere i grandi della terra; il purgatorio , invece, rappresentato con vasche di purificazione e con Giona dalla cui bocca spunta un corpo purificato.
 Giudizio universale, affresco, XIII e XIV secolo, particolare, navata destra.
Giudizio universale, affresco, XIII e XIV secolo, particolare, navata destra.
L'affresco misura m.5,40 x 3,92 ed suddiviso in pi registri:
- nel registro superiore, del XIII secolo, vi la raffigurazione del Giudizio universale e S. Michele, attribuita a Rinaldo da Taranto.
Le scene dell'inferno mostrano la punizione inflitta ai peccatori.
 Giudizio universale, affresco, XIII e XIV secolo, registro inferiore, navata destra.
Giudizio universale, affresco, XIII e XIV secolo, registro inferiore, navata destra.
Il ciclo di affreschi misura m.5,40 x 3,92 ed suddiviso in pi registri:
- nel registro inferiore vi sono una Madonna con Bambino e i Ss. Pietro, Giuliano e Luca, dipinti da Ignoto del XIV secolo.
- Nel registro superiore vi la raffigurazione del Giudizio universale.
 Capitelli figurati, materiale lapideo, XIII secolo.
Capitelli figurati, materiale lapideo, XIII secolo.
I capitelli coronano i sei fusti di granito e sono uno diverso dall'altro. Su essi poggiano le sei arcate a tutto sesto che caratterizzano l'interno della chiesa.
 Soffitto centrale, XVIII-XIX secolo.
Soffitto centrale, XVIII-XIX secolo.
Il soffitto, originariamente a capriate, è oggi formato da un piano ligneo del Settecento sul quale sono stati applicati tre teleri. In direzione => presbiterio: Estasi di S. Giovanni da Matera, Visitazione, Apparizione della croce a S. Eustachio, tutti dipinti dal calabrese Giovanni Battista Santoro nel 1809.
Intonaco, stucchi, dorature sono pensati nel 1703 da mons. Brancaccio (1703-1722) ma portati a termine nel 1776 da mons. Zunica (1776-1796). Tra il 1862 e il 1865 le cornici e gli stucchi indorati vengono ripresi con oro zecchino.
 G. Battista Santoro, S. Giovanni da Matera, tela, XIX secolo, soffitto navata centrale.
G. Battista Santoro, S. Giovanni da Matera, tela, XIX secolo, soffitto navata centrale.
"Sotto il tavolato del contesto pittorico-decorativo settecentesco, furono anche attaccate nell'Ottocento, in maniera omogenea con l'apparato circostante, tre tele", opera di Giovanni Battista Santoro, pittore calabrese, vissuto dal 1809 al 1895.
S. Giovanni di Matera qui rappresentato "in gloria". E' ricordato per due motivi: eremita, riceve l'ordine da san Pietro di restaurare la Chiesa (un secolo dopo ad Assisi il Crocifisso ordinerò la stessa cosa a Francesco); fonda una Congregazione di monaci detti, dal nome della località, di Pulsano, ai quali applica la regola benedettina in modo rigido. Muore in fama di santità nel 1139.
 G. Battista Santoro, La Visitazione di Maria a Santa Elisabetta, tela, XIX secolo, soffitto navata centrale.
G. Battista Santoro, La Visitazione di Maria a Santa Elisabetta, tela, XIX secolo, soffitto navata centrale.
"Sotto il tavolato del contesto pittorico-decorativo settecentesco, furono anche attaccate, nell'Ottocento, in maniera omogenea con l'apparato circostante, tre tele", opera di Giovanni Battista Santoro, pittore calabrese, vissuto dal 1809 al 1895, "L'effetto ultimo quello dello "sfondamento", caratteristico del barocco, che ottenuto attraverso le finte architetture, in cui ben si stagliano le immagini" (Di Pede).
 Altobello Persio, Cristo Risorto, pietra dipinta, 1540.
Altobello Persio, Cristo Risorto, pietra dipinta, 1540.
Gli evidenti segni della Passione fanno pensare subito ad un'opera destinata al culto devozionale. La figura presenta qualche squilibrio nelle proporzioni: la mano destra pi grande della sinistra, l'addome appare troppo turgido. Recentemente restaurata, la statua ha svelato la presenza di dorature sul perizoma, il che lascia supporre che originariamente esso fosse interamente dorato.
"Il senso di robustezza delle figure consueto nelle opere di Altobello; l'artista prosegue, con grande schiettezza, il discorso, più volte definito naturalistico e alquanto popolareggiante" (De Mase).
(cfr. Scheda - Altobello Persio)
 Ignoto, Crocifisso, scultura lignea policroma, XVII secolo.
Ignoto, Crocifisso, scultura lignea policroma, XVII secolo. Andrea Miglionico, Sacra Famiglia coi Ss. Gioacchino ed Anna, tela, XVII secolo.
Andrea Miglionico, Sacra Famiglia coi Ss. Gioacchino ed Anna, tela, XVII secolo. Andrea Miglionico, Visitazione, tela, XVII secolo.
Andrea Miglionico, Visitazione, tela, XVII secolo. Francesco Celebrano, Immacolata e i Ss. Francesco, Domenico, Antonio e Chiara, tela, XVIII secolo.
Francesco Celebrano, Immacolata e i Ss. Francesco, Domenico, Antonio e Chiara, tela, XVIII secolo. Domenico Polino, Crocifissione, tela, XVII secolo, sacrestia.
Domenico Polino, Crocifissione, tela, XVII secolo, sacrestia.