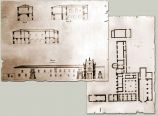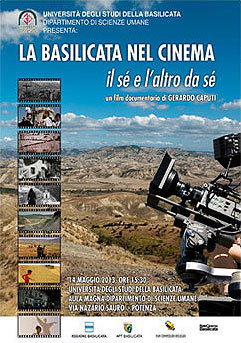Nel 1615, a seguito di bolla pontificia, inizia la costruzione del Convento dei francescani Minori Riformati. E' eretto nella parte nord del paese, non lontano dal monticello detto "lu 'mpiso" (luogo d'impiccagione, in seguito denominato Calvario).
Ben presto acquista prestigio per la qualità degli studi in esso compiuti e perché dotata di una ricca biblioteca contenente anche opere profane (cosa insolita per una biblioteca ecclesiastica dell'epoca).
In una relazione del 1674, indirizzata al re, si legge che tale convento "il decoro et il specchio di questa terra e i frati sono nel Regno veramente osservanti, et i più esemplari, e pochi altri l'uguagliano nel buon esempio che danno" (Ardoini).
La legge eversiva della feudalità del 1806, con cui furono soppressi anche gli Ordini religiosi, non tocca questo convento perché privo di possedimenti (i frati ricevevano, infatti, un contributo per il sostentamento dal Comune).
Nel 1861 lo stabile ospita le truppe piemontesi fino al '66, anno in cui diventa proprietà del Comune. Il quale sottoscrive l'impegno di custodire la ricca biblioteca. Non mantenne però gli impegni permettendo che essa fosse depredata nel corso degli anni (solo una piccola parte dei volumi si trovano nel convento di S. Maria a Potenza). E' stato, inoltre, fautore dello scempio del convento: ha abbattuto muri interni, aperto porte, ha affittato i locali, alcuni dei quali ad uso di un pastificio.
L'illustre aviglianese Emanuele Gianturco, ministro dei Lavori Pubblici, fa' acquisire il convento dal dicastero di grazia e giustizia, che lo trasforma in Riformatorio minorile, aperto fino alla metà degli anni Novanta del Novecento. Ora tornato alla gestione comunale...
La facciata stata rifatta nell' "A.D.1786" (come si legge sul frontale) ed costituita da una parte centrale e due facce oblique ai lati. E' in pietra liscia e organizzata secondo un sobrio stile barocco. Una cornice, anch ' essa in pietra, delimita il portale. Lo sovrasta
una finestra ad arco a tutto sesto.
I lati obliqui sono delimitati da leséne con nicchia nella parte inferiore, e due oculi in quella superiore. La facciata termina con un frontone curvilineo su cui sono poste tre statue dei Ss. Francesco, Maria, Antonio.
La chiesa nasce poco dopo il convento, fondato nel 1615. Chiusa al culto nel 1866, l'anno successivo riaperta e affidata all'ex guardiano del convento. Dal 1900 passa sotto la giurisdizione del clero secolare locale.
 Portale, materiale lapideo, XVIII secolo.
Portale, materiale lapideo, XVIII secolo.
Una cornice in pietra delimita il portale, il cui architrave pare sorretto da teste d'angelo, che sono però soltanto ornamentali.
 Frontone della facciata, 1786.
Frontone della facciata, 1786.
La facciata termina con un frontone curvilineo su cui sono poste tre statue, dei Ss. Francesco, Maria e Antonio.
 Portale, parte destra dell'architrave, XVIII secolo.
Portale, parte destra dell'architrave, XVIII secolo.
L'architrave pare poggiare su due teste di putti, che sono però soltanto ornamentali e che fanno pendant con motivi floreali collocati sull'angolo esterno.
L'interno si presenta a due navate: la principale, lunga m. 32x7, ha una volta a botte lunettata più alta di quella laterale, la quale misura m. 19x5 e ha la volta a crociera. La prima, coi suoi stucchi e cornici, si contrappone alla seconda, sobria nella decorazione.
La navata principale termina con l'abside.
 Ignoto, Altare della Madonna con Bambino e i Ss. Michele e Gregorio, legno policromato, XVIII secolo, navata laterale.
Ignoto, Altare della Madonna con Bambino e i Ss. Michele e Gregorio, legno policromato, XVIII secolo, navata laterale.
Del pittore Cenatiempo si posseggono documenti che vanno soltanto dal 1702 al 1730.
(cfr. Scheda - Girolamo Cenatiempo)
 Ignoto, Altare di St. Maria degli Angeli, legno policromato, XVIII secolo.
Ignoto, Altare di St. Maria degli Angeli, legno policromato, XVIII secolo.
Ignoto meridionale, S. Maria degli angeli, statua lignea, XVIII secolo, Altare di S. Maria degli Angeli.
 Girolamo Bresciano, Porziuncola, tela, 1628.
Girolamo Bresciano, Porziuncola, tela, 1628.
Collocata sul IV altare della parete sinistra, tale altare collocato nell'area del presbiterio ed il pi grande della chiesa.
La tela, di una semplicità ascetica, risponde ai canoni della pittura nata dalla Controriforma ed organizzata secondo lo stile anedottico degli ex-voto.
E' curioso notare come i due santi collocati in basso, Antonio e Agostino, sembrino essere estranei alla scena rappresentata da Maria e Cristo che appaiono in sogno a Francesco.
(cfr. Scheda - Girolamo Bresciano)
 Ignoto, Altare di S. Francesco, legno policromato, XVIII secolo; S. Francesco scultura lignea, XVII secolo.
Ignoto, Altare di S. Francesco, legno policromato, XVIII secolo; S. Francesco scultura lignea, XVII secolo.
Una serie di altari lignei intagliati, dorati e di stile barocco, posta lungo la parete sinistra della navata principale. E' opera di un raffinato intagliatore. Questo altare dorato e costruito con un virtuosismo decorativo e fornisce un suggestivo effetto plastico per l'organizzazione delle figure che lo ornano (cariatidi e putti).
 Cariatide, scultura lignea, particolare, Altare di S. Francesco, XVIII secolo.
Cariatide, scultura lignea, particolare, Altare di S. Francesco, XVIII secolo.
 Putti ornamentali, scultura lignea, XVIII secolo, particolare, Altare di S. Francesco.
Putti ornamentali, scultura lignea, XVIII secolo, particolare, Altare di S. Francesco.
 Filippo Ceppaluni, Ss. Pasquale Baylon e Pietro d'Alcantara, tela, 1745 e Ignoto, Altare, legno policromato, XVIII secolo.
Filippo Ceppaluni, Ss. Pasquale Baylon e Pietro d'Alcantara, tela, 1745 e Ignoto, Altare, legno policromato, XVIII secolo.
Una serie di altari lignei intagliati, dorati e di stile barocco, posta lungo la parete sinistra della navata principale.
Questo il primo. Contiene la tela del 1745 dipinta da Filippo Ceppaluni, detto il Muto e allievo di Luca Giordano (1632-1705). Di questi egli risente molto l'impianto figurativo. Sua anche l'immagine della Madonna del Carmine collocata nella cimasa. Era noto ai suoi tempi soprattutto per la sua capacità di dipingere ritratti.
Molte guide riportano ancora la notizia che dei due santi raffigurati nella tela uno san Giovanni della Croce invece che S. Pietro d'Alcantara. In realtà il primo, uno dei pi grandi mistici dell'Occidente, essendo stato frate domenicano (1542-1591), non figurava mai nella iconografia francescana.
Il secondo fu francescano, nato in Spagna nel 1499, anche lui grande mistico ammirato da santa Teresa d'Avila e dall'imperatore Carlo V, che lo avrebbe voluto per confessore.
(cfr. Scheda - Filippo Ceppaluni)
 Filippo Ceppaluni, Madonna del Carmine, tela, XVIII secolo.
Filippo Ceppaluni, Madonna del Carmine, tela, XVIII secolo.
La tela collocata nella cimasa del primo altare ligneo dei Ss. Pasquale Baylon e Pietro d'Alcantara.
(cfr. Scheda - Filippo Ceppaluni)
 Cantoria e organo, legno policromato, XVIII secolo.
Cantoria e organo, legno policromato, XVIII secolo.
"La cantoria sembra essere stata smontata e riadattata per occupare esattamente lo spazio dell'abside, destinato ad accogliere l'organo. Lo farebbero pensare gli inserti laterali di legname povero e non decorato a differenza del pannello centrale, che rievoca l'idea di un paliotto d'altare, e dei due angolari" (Sopraintendenza).
 Ignoto, Crocifisso tra Maria Addolorata e S. Giovanni Evangelista.
Ignoto, Crocifisso tra Maria Addolorata e S. Giovanni Evangelista.
Le sculture appartengono al XVIII secolo: il Crocifisso in legno policromato, l'Addolorata e S Giovanni Evangelista sono in cartapesta policromata. Queste due ultime sono di fattura pregevole, soprattutto Maria. Tutte le statue sono di ignoto meridionale.
 Ignoto, Altare della Passione, legno policromato, XVII secolo, navata laterale.
Ignoto, Altare della Passione, legno policromato, XVII secolo, navata laterale.
Il Crocifisso collocato in una nicchia sopra l'altare ed ha ai suoi lati le statue dell'Addolorata e di S. Giovanni Evangelista. Questo tipo di rappresentazione ricorrente nelle chiese francescane della regione.
 Pietro Antonio Ferro, Incoronazione di Maria e i Ss. Bonaventura da Bagnoregio e Bernardino da Siena, e, in basso, S. Lucia, tela, XVII secolo.
Pietro Antonio Ferro, Incoronazione di Maria e i Ss. Bonaventura da Bagnoregio e Bernardino da Siena, e, in basso, S. Lucia, tela, XVII secolo.
“La composizione dell’opera, equilibrata e simmetrica, evidenzia una struttura solida di masse e di volumi.” Gli angeli hanno una fisionomia uguale a quella del Bambino. Ai lati i due santi francescani, “come due colonne a sostegno del grande cerchio, equilibrano la composizione. Il dipinto alle forme trepide e patetiche del tardomanierismo associa felicemente quella gentile malinconia (molto cara al Barocci) e quel sottile naturalismo (caro al Santafede), ricorrenti nelle opere più mature del Ferro” (Colangelo).
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)