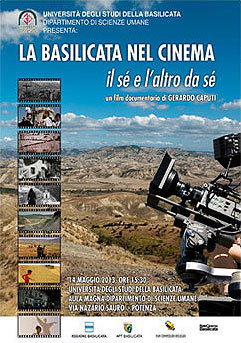La struttura sociale di Venusia era, come il resto della società romana, a base piramidale, con al vertice le classi dirigenti, al centro la massa del populus, contadini, piccoli proprietari ed artigiani ed alla base la classe servile. Ai margini di questa struttura si collocavano i liberti, gli ex-schiavi, che, se per origine erano di rango inferiore, riuscirono, soprattutto a partire dall’epoca imperiale, ad assicurarsi posizioni di visibilità sociale, grazie anche alle notevoli possibilità finanziarie.
Le classi dirigenti di Venusia, i cosiddetti Domi nobiles, erano fondamentalmente un’aristocrazia terriera, anche se talvolta accrescevano i loro proventi con attività non connesse con l’agricoltura: i suoi rappresentanti erano i discendenti degli antichi coloni del 291 a.C., cui si aggiunsero i veterani della legio XII, all’atto della rifondazione del 43 a.C.
Le possibilità di ascesa sociale, possono essere esemplificate dalla storia della famiglia dei Salvii. Il primo di cui si ha menzione da fonti epigrafiche, all’inizio dell’età augustea, è C. Salvius Capito, già possessore d’ingenti proprietà. Da iscrizioni di pertinenza del sepolcro familiare, si ha notizia di una squadra gladiatoria appartenente allo stesso Capito. Il mestiere di lanista, cioè di impresario gladiatorio, non era certo di grande lustro sociale, ma fornì grande pubblicità alla famiglia dei Salvi. Da ciò trassero vantaggio alcuni discendenti che si dedicarono all’attività politica: un tal C. Salvius Bubulcus, quaestor nel 34 A.C.., ed un L. Salvius L. F., che fu duoviro e curatore dell’acquedotto di Venusia in età tardoaugustea.
Dal punto di vista politico all’inizio Venusia fu una colonia sottoposta allo ius latinum. Le magistrature in questo periodo furono, per quanto riguarda quelle maggiori, la censura, la pretura e l’edilità, per quanto riguarda quelle minori, il tribunato della plebe (che aveva anche competenze in materia edilizia) e la questura (che svolgeva un’attività di controllo sulle proprietà pubbliche e private). La colonia aveva anche un proprio senatus, formato dagli ex magistrati maggiori.
A partire dal 90 A.C.. gli abitanti di Venusia diventarono, come tutti gli altri Latini, cittadini romani a tutti gli effetti. La colonia fu così trasformata in municipium, mutando quindi radicalmente il suo status politico.
L’ulteriore, e logico, mutamento fu la trasformazione, nel 43 a.C.., del municipium in colonia romana. Il mutamento ebbe effetto non tanto dal punto di vista della cittadinanza quanto da quello della struttura sociale, in virtù dell’immissione dei veterani della XII legione che ricevettero le terre espropriate ai locali.
Le magistrature si uniformarono a quelle delle altre colonie romane: il senato fu trasformato in ordo decurionum (i decurioni erano così chiamati in quanto scelti per decurie, per un totale di cento membri), era presente una magistratura giurisdicente, il duovirato (formata appunto da due magistrati), una con compiti di polizia urbana, gli aediles (anch’essi in numero di due), e, almeno a partire dal 34 a.C., una con incarico di sorveglianza ed ispezione sulle finanze pubbliche, i quaestores. A queste si affiancava quella dei duoviri quinquennales, che ogni cinque anni effettuava il censimento delle persone e delle proprietà pubbliche.
Di notevole importanza erano anche le cariche religiose, da quelle tradizionali come i pontifices e gli augures, a quelle destinate al culto imperiale come i flamines.
La struttura triadica, senato, magistratura, populus, era affiancata da istituzioni con carattere politico—religioso, istituite per volontà di Augusto: gli Augustales, organizzazione parallela a quella magistratuale e formata da liberti, cioè ex-schiavi, che vi aderivano per ottenere quel prestigio sociale altrimenti negato a causa della loro origine servile.
Ultimo tassello dell’organizzazione sociopolitica venusina era rappresentato dai collegia, associazioni professionali come il collegium aquanorum, associazione degli acquaioli.
Per quanto riguarda l’economia venusina è chiaro che agli inizi fu basata essenzialmente, per non dire unicamente, sull’attività agricola, rappresentata dalle culture ceralicole. La posizione favorevole della colonia, posta al punto di incontro tra l’entroterra appenninico e le pianure apule, fece si che, almeno a partire dal periodo imperiale, a Venosa fossero create attività manifatturiere e mercantili, come lo smercio di mercanzie e fabbriche di laterizi (figlinae), grazie soprattutto all’azione dei liberti, le cui ingenti ricchezze procurate con queste attività (ricordiamo un’epigrafe che parla di un ricco unguentarium, cioè un profumiere in contatto con i ricchi mercati dell’Oriente), sono testimoniate dall’edificazione di ricchi monumenti funerari, a noi noti da resti od iscrizioni. Tali monumenti attestano anche la presenza di un folto gruppo di artigiani e lavoranti della pietra.
Venosa, ebbe una propria monetazione monetaria in bronzo per un periodo ristretto, nel III secolo a.C. La tipologia di questa monetazione, qantitativamente limitata ma assai importante dal punto di visto storico e formale, è del tutto originale: abbiamo Ercole, rappresentato a mezzo busto, con sul rovescio la figura del leone nemeo, Bacco seduto, il rospo visto dall’alto, il calzare alato di Mercurio. Tutti i soggetti sono in rapporto con i principali culti della colonia e con l’interesse per il mondo naturale e le attività venatorie. Dal punto di vista tecnico la monetazione era divisa in due guppi: quello dell’aes grave, formato cioé da monete assai grandi ottenute tramite fusione, e quello delle monete coniate, cioè create tramite un modello, conio, sul quale la lamina bronzea era martellata.