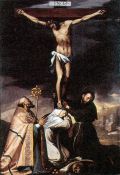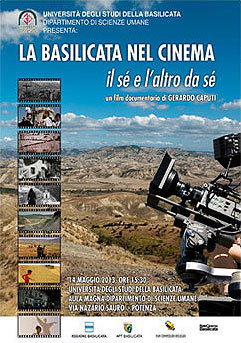Chiostro, 1605-1626
I Carmelitani si insediano a Tricarico nel 1605 su sollecitazione del nobile Giovanni Antonio Russo, il quale, morendo, destina all'Ordine monastico un considerevole lascito utile sia all'edificazione del convento sia della chiesa annessa. Entrambi sono di dimensioni modeste ma interessanti per le opere pittoriche che vi contengono.
Nel chiostro hanno lavorato Carlo e Giovanni Ferro, figli del prestigioso Pietro Antonio, originari di Tricarico, dipingendo nelle lunette Scene bibliche relative ad Elia ed Eliseo, Storie dell'ordine carmelitano, e nei tondi santi e vescovi dell'Ordine.
 Carlo e Giovanni Ferro, Affreschi del chiostro, 1642.
Carlo e Giovanni Ferro, Affreschi del chiostro, 1642.
- mons. Serapione, mons. Eutrobio; fra' Gugliemo;
- Vescovo; fra' Andrea; san Carlo.
 Carlo e Giovanni Ferro, Sante dell'Ordine domenicano, affreschi del chiostro, 1642.
Carlo e Giovanni Ferro, Sante dell'Ordine domenicano, affreschi del chiostro, 1642.
 Chiesa del Carmelo, Portale, materiale lapideo, 1605.
Chiesa del Carmelo, Portale, materiale lapideo, 1605.
 Chiesa del Carmelo, Interno, 1612.
Chiesa del Carmelo, Interno, 1612.
Sulle antiche fondamenta della chiesa di S. Maria del Soccorso i Carmelitani scalzi, che avevano iniziato la costruzione del loro convento nel 1605, riedificano la chiesa nel 1612. Quest'ultima a navata unica terminante con un presbiterio quadrato. Entrambi gli edifici sono stati affrescati da Pietro Antonio Ferro e i figli Carlo e Giovanni, nativi di Tricarico.
(Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Strage degli innocenti, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
Pietro Antonio Ferro, Strage degli innocenti, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Trasfigurazione, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
Pietro Antonio Ferro, Trasfigurazione, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Angeli con i simboli della Passione, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
Pietro Antonio Ferro, Angeli con i simboli della Passione, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Angeli coi simboli della Passione, affresco, 1612-1616, particolari, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
Pietro Antonio Ferro, Angeli coi simboli della Passione, affresco, 1612-1616, particolari, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Circoncisione , affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
Pietro Antonio Ferro, Circoncisione , affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
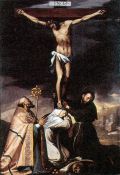 Pietro Antonio Ferro, Crocifissione coi Ss. Francesco d'Assisi e Gerardo vescovo, tela, 1616, Chiesa del Carmelo.
Pietro Antonio Ferro, Crocifissione coi Ss. Francesco d'Assisi e Gerardo vescovo, tela, 1616, Chiesa del Carmelo.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Giovan Battista Ferro, Incontro di Gesù con la Madre, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
Giovan Battista Ferro, Incontro di Gesù con la Madre, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
Nei Vangeli non si riscontra un passo in cui venga descritto il genuflettersi di Gesù davanti a sua Madre. Evidentemente il committente aveva necessità di creare un'immagine con cui proporre didatticamente il quarto comandamento, "onora il padre e la madre".
 Pietro Antonio Ferro, Scena di vita familiare con Maria e il Bambino e, sulla destra, Giuseppe che sega, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
Pietro Antonio Ferro, Scena di vita familiare con Maria e il Bambino e, sulla destra, Giuseppe che sega, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete sinistra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Giovan Battista Ferro, Arco trionfale con (a salire) S. Girolamo, S. Gregorio, S. Ambrogio, affresco, 1612-1616, particolare, Chiesa del Carmelo, sottarco.
Giovan Battista Ferro, Arco trionfale con (a salire) S. Girolamo, S. Gregorio, S. Ambrogio, affresco, 1612-1616, particolare, Chiesa del Carmelo, sottarco.
 Pietro Antonio Ferro, S. Rocco, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, arco trionfale, lato destro.
Pietro Antonio Ferro, S. Rocco, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, arco trionfale, lato destro.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Annunciazione, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, arco trionfale, retro.
Pietro Antonio Ferro, Annunciazione, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, arco trionfale, retro.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Scorcio della parte superiore del presbiterio:
Pietro Antonio Ferro, Scorcio della parte superiore del presbiterio:
- Arco trionfale con (nel sottarco, da sinistra) i Ss. Girolamo, Gregorio, Ambrogio e Agostino.
- Sottarchi di destra e di sinistra: I 12 Apostoli.
- Parte superiore della parete di fondo del presbiterio: tondi raffiguranti (da sinistra) S. Francesco d'Assisi, Cristo Redentore, S.Francesco da Paola; (ovale orizzontale) Nascita di S. Giovanni Battista.
- Chiave della volta: Assunta e sepolcro vuoto; affreschi, 1612-1616, Chiesa del Carmelo.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Adorazione dei Magi, affresco, 1612 - 1616, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete sinistra.
Pietro Antonio Ferro, Adorazione dei Magi, affresco, 1612 - 1616, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete sinistra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Il Profeta Elia e, (sopra), S. Francesco (tondo), affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete centrale.
Pietro Antonio Ferro, Il Profeta Elia e, (sopra), S. Francesco (tondo), affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete centrale.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Il Profeta Elia e, (sopra), S. Francesco (tondo), affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete centrale.
Pietro Antonio Ferro, Il Profeta Elia e, (sopra), S. Francesco (tondo), affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete centrale.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Il Profeta Eliseo, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete centrale.
Pietro Antonio Ferro, Il Profeta Eliseo, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete centrale.
Eliseo fu profeta, successore di Elia. Ricco possidente, alla morte di Elia ne ereditò il mantello e due terzi delle virtù carismatiche. Conserva le sue abitudini di agiato borghese e opera molti miracoli: divide le acque del Giordano, rende salubre la fonte di Gerico, moltiplica l’olio di una vedova per liberarla da uno strozzino, moltiplica 20 pani per un centinaio di persone, ed altri miracoli ancora. Morì nel 790 a.C. e a contatto con le sue ossa un morto, se degno, resuscitava.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Fuga in Egitto (a sinistra) e Sogno di Giuseppe (a destra), affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Fuga in Egitto (a sinistra) e Sogno di Giuseppe (a destra), affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete destra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Fuga in Egitto, affresco, 1612, particolare, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Fuga in Egitto, affresco, 1612, particolare, Chiesa del Carmelo, presbiterio, parete destra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 1612-1616, Chiesa del Carmelo, piano di imposta della volta.
1612-1616, Chiesa del Carmelo, piano di imposta della volta.
La raffigurazione delle Virtù ha le sue orgini letterarie in S.Tommaso, fra' Bartolomeo da S. Concordio, ma soprattutto nella Psycomachia, poema di Prudenzio, scritto agli inizi del sec. V. Il soggetto ha informato l'iconografia occidentale dal Medioevo all'Ottocento, toccando livelli artistici memorabili nel Rinascimento.
Molto spesso esse sono state personificate da vergini guerriere in atto di abbattere i vizi sotto sembianze demoniache, o sedute in trono.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Cupola a padiglione con, nella chiave, Assunta e sepolcro vuoto, affreschi, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, presbiterio.
Pietro Antonio Ferro, Cupola a padiglione con, nella chiave, Assunta e sepolcro vuoto, affreschi, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, presbiterio.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Dormizione di Maria, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Dormizione di Maria, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, parete destra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Discesa dello Spirito Santo nel cenacolo, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Discesa dello Spirito Santo nel cenacolo, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, parete destra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Gesù disputa con i Dottori della Legge nel tempio di Gerusalemme, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Gesù disputa con i Dottori della Legge nel tempio di Gerusalemme, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete destra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Fuga in Egitto, affresco 1612, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Fuga in Egitto, affresco 1612, Chiesa del Carmelo, parete destra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Sposalizio della Vergine, affresco, 1612-1616, particolare, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Sposalizio della Vergine, affresco, 1612-1616, particolare, Chiesa del Carmelo, parete destra.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, I miracoli di sant'Alberto da Messina, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, I miracoli di sant'Alberto da Messina, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Le due scene raffigurano due momenti della vita del carmelitano siciliano, nato nel 1225 e divenuto molto popolare per le sue virtù taumaturgiche: la ricomposizione delle membra di un bambino fatto a pezzi per essere mangiato dai genitori durante la terribile carestia che colpì Messina (registro superiore) e la guarigione di un moribondo (registro inferiore).
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Sant'Alberto da Messina, affresco, 1612, particolare, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Sant'Alberto da Messina, affresco, 1612, particolare, Chiesa del Carmelo, parete destra.
La scena riproduce uno dei numerosi miracoli compiuti dal santo carmelitano siciliano, nato nel 1225: la ricomposizione delle membra di un bambino ridotto in pezzi dai genitori per essere mangiato durante la terribile carestia che aveva colpito la città di Messina.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Pietro Antonio Ferro, Sant'Alberto da Messina predica ai pesci, affresco, 1612, particolare, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Sant'Alberto da Messina predica ai pesci, affresco, 1612, particolare, Chiesa del Carmelo, parete destra.
La scena riproduce uno dei numerosi miracoli compiuti dal santo carmelitano siciliano, nato nel 1225: la predicazione ai pesci al fine di richiamare l'attenzione dei cristiani, indifferenti alle pratiche religiose.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Giovan Battista Ferro, La Vergine in gloria con la SS. Trinità, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, parete di destra.
Giovan Battista Ferro, La Vergine in gloria con la SS. Trinità, affresco, 1612-1616, Chiesa del Carmelo, parete di destra.
 Pietro Antonio Ferro, Santa Teresa D’Avila, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Pietro Antonio Ferro, Santa Teresa D’Avila, affresco, 1612, Chiesa del Carmelo, parete destra.
Al tempo dell’esecuzione dell’affresco Teresa era ancora canonicamente “Beata”. Vissuta dal 1515 al 1582, è qui ritratta nell’atto di stendere le Regole riformatrici del Carmelo: ella fondò, infatti, l’Ordine dei Carmelitani scalzi e numerosi conventi, sia maschili che femminili, nei quali l'ascetismo non fosse una parola priva di significato.
Appartenente ad una delle famiglie più potenti della Spagna di Filippo II (1556-1598), benché grande mistica, non trascurò gli aspetti economici dei molti conventi da lei fondati. Soleva dire: “Teresa senza la grazia di Dio è una povera donna. Con la grazia di Dio, una forza. Con la grazia di Dio e molti danari, una potenza”. Per il suo elevato grado di misticismo e di scienza teologica è stata proclamata Dottore della Chiesa.
(cfr. Scheda - Pietro Antonio Ferro)
 Portale, scultura lapidea, 1763.
Portale, scultura lapidea, 1763. Interno, 1751, visto dal presbiterio.
Interno, 1751, visto dal presbiterio. Stefano Sparano, Polittico, dipinto su tavola, 1545, sacrestia.
Stefano Sparano, Polittico, dipinto su tavola, 1545, sacrestia. Stefano Sparano, S. Pietro, dipinto su tavola, 1545, particolare.
Stefano Sparano, S. Pietro, dipinto su tavola, 1545, particolare. Stefano Sparano, Annunziata, dipinto su tavola, 1545, particolare.
Stefano Sparano, Annunziata, dipinto su tavola, 1545, particolare. Ignoto, S. Rocco, statua lignea, XVI secolo.
Ignoto, S. Rocco, statua lignea, XVI secolo.